L’utilità marginale decrescente
L’utilità marginale decrescente è un principio fondamentale della teoria economica, secondo cui il beneficio (o utilità) che un consumatore ricava dal consumo di una stessa unità di bene diminuisce man mano che il consumo aumenta.
In altre parole: più ne hai, meno ti serve. Ad esempio, se sto mangiando una mela, ogni morso conta meno del precedente
Quando si consuma qualcosa, ogni unità aggiuntiva di un bene genera utilità positiva al consumatore, ma sempre più bassa rispetto alla precedente.
Questo non significa che il bene diventa inutile, ma che il valore soggettivo che gli attribuiamo cala con l’uso ripetuto.
A cosa serve? L’utilità marginale decrescente spiega perché accumulare non è sempre razionale e perché le risorse vanno allocate dove generano il maggior beneficio. Capirla è il primo passo per interpretare scelte di consumo, politiche fiscali e il valore soggettivo dei beni.
Esempio pratico
Prendo l'esempio tipico di una pizza.
La prima fetta mi soddisfa moltissimo. E' un piacere per il palato.
La seconda è ancora buona, ma un po’ meno essenziale.
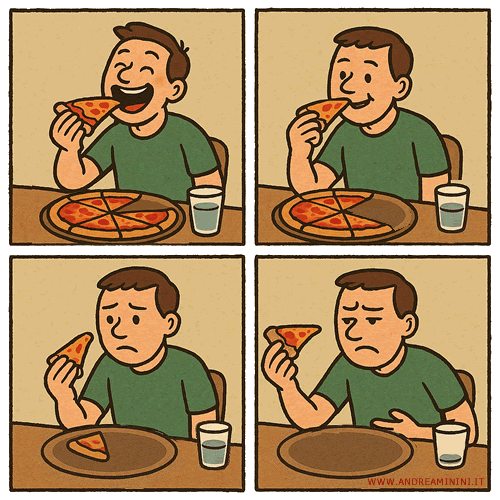
Alla quarta, forse comincio a essere sazio, e il desiderio inizia a calare.
La settima fetta potrebbe persino darmi fastidio. E a quel punto, più che godermi la cena, me la starei solo rovinando per onorare il mito del "non si spreca nulla.
Nota. Ovviamente si tratta di qualcosa di soggettivo. Personalmente, mangerei volentieri anche due pizze di fila… ma alla terza comincerei senz’altro a sentirmi male. Il punto, però, resta invariato: il piacere che proviamo nel fare qualcosa tende a diminuire man mano che la ripetiamo. È una regola che vale per tutti, sebbene con intensità diverse.
L'aspetto matematico dell'utilità marginale decrescente
Il concetto dell'utilità marginale decrescente si traduce in modo semplice nella matematica economica.
Tuttavia, bisogna sapere almeno i fondamenti dell'analisi matematica, in particolar modo il concetto di funzione e di derivata.
L’utilità totale \( U(x) \) è una funzione crescente ma concava. Ha un grafico che sale, ma poi inizia a "piegarsi".
In altre parole, cresce con le quantità consumate di un bene... ma sempre di meno.
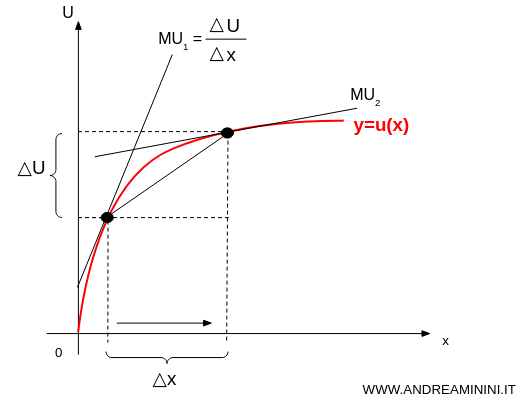
Dal punto di vista matematico questo vuol dire che:
- La prima derivata \( U'(x) \), cioè l’utilità marginale, è positiva ma decrescente.
- La derivata seconda è **negativa \( U''(x) < 0 \) perché la curva è concava verso il basso. Un po' come il divertimento quando un gioco dura troppo.
Per capirlo meglio, osservo questa sequenza:
| Unità consumate | Utilità marginale (ΔU) |
|---|---|
| 1 | 10,0 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 3,0 |
| 5 | 2,0 |
| 6 | 1,0 |
| 7 | 0,0 |
Nota. In questa tabella ho ipotizzato che l'utilità fosse misurabile... in realtà non lo è, perché è soggettiva. E' solo una semplificazione utile per spiegare meglio il concetto di utilità marginale decrescente.
Come si può notare, ogni nuova unità consumata aggiunge meno soddisfazione della precedente.
Non è che il bene valga meno in sé, ma lo apprezzo meno perché ne ho già consumato tanto. Un po’ come le riunioni aziendali: dopo la prima, capisci tutto; dopo la quinta, sogni la pensione.
Quindi, la funzione dell'utilità marginale scende con l’aumentare del consumo.
Il suo grafico si presenta come una curva decrescente, più si consuma, più la curva si abbassa, fino quasi a toccare lo zero.
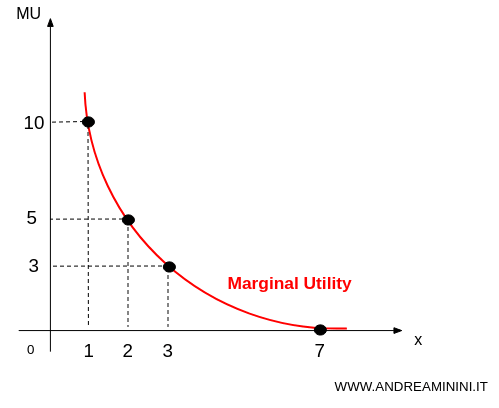
Esattamente come la concentrazione e la voglia di studiare alla quarta ora di lezione consecutiva.
La teoria
Il concetto dell'utilità marginale venne formulato in modo rigoroso per la prima volta nell’Ottocento da Hermann Heinrich Gossen, un autore poco noto al grande pubblico ma di importanza capitale.
La sua "legge" stabiliva con chiarezza che la soddisfazione (utilità) derivante dal consumo di un bene diminuisce man mano che quel bene viene consumato.
Poi arrivarono William Stanley Jevons e Léon Walras, che inserirono questa intuizione nella cornice matematica della teoria dello scambio e dell’equilibrio generale.
Con loro, l’economia cominciò a trattare le decisioni individuali non più come atti isolati ma come elementi inseriti in un sistema interconnesso.
Infine, fu Alfred Marshall a dare al concetto la sua consacrazione definitiva, integrandolo nella teoria del benessere economico.
Per lui, capire quanto valore attribuisce un individuo all’ultima unità consumata era il primo passo per misurare l’efficacia delle politiche pubbliche.
La legge dell’utilità decrescente è il pilastro di tutta l’economia marginalista, quella branca dell’economia che analizza le decisioni a piccoli passi. Non si tratta di scegliere tra tutto o niente, ma di decidere se vale la pena aggiungere una unità in più.
Questa logica si applica a ogni scelta: lavorare un’ora in più, acquistare un altro prodotto, risparmiare o spendere.
Esempio. Un’azienda decide se produrre un pezzo in più valutando il costo e il beneficio marginale. Se il ricavo è inferiore al costo aggiuntivo, non conviene. Semplice, ma essenziale.
L’esauribilità dei bisogni
Alla base di tutto c’è un’idea di disarmante semplicità: i bisogni si esauriscono.
Questo vale per ogni bene: dopo un certo punto, continuare a consumare aggiunge sempre meno utilità. In termini tecnici, si dice che l’utilità marginale decresce.
Quali sono le implicazioni in politica economica?
Questo principio ha ricadute forti sulle politiche di redistribuzione, equità e giustizia economica.
Se un euro in più vale di più a chi ha poco e di meno a chi ha tanto, allora redistribuire il reddito può aumentare l’utilità totale in una società.
Esempio. Se lo Stato toglie 100 euro a chi guadagna 10.000 euro al mese e lo dà a chi ne guadagna 500, l’effetto sul benessere complessivo potrebbe essere positivo, perché quei cento euro hanno un’utilità marginale molto più alta per il secondo.
E' uno dei motivi per cui lo Stato applica la progressività fiscale, ossia aliquote più alte oltre un certo scaglione di reddito.
E così via.
