L'utilità
L’utilità rappresenta il piacere o la soddisfazione soggettiva che un individuo ottiene dal consumo di un bene o di un servizio, in relazione alla sua capacità di soddisfare un bisogno.
L'utilità è ciò che lega il desiderio alla scelta, l’offerta alla domanda, il consumo alla soddisfazione.
Ma per essere rilevante in economia, non basta che un bene procuri piacere, deve anche essere limitato e consapevolmente apprezzato.
Le caratteristiche dell'utilità
L'utiltià è un concetto fondamentale dell’economia, ma dietro questa parola semplice si nasconde un’intera architettura di significati.
Innanzitutto, l'utilità è un concetto soggettivo e relativo.
- L'utilità è soggettiva
L’utilità non è una grandezza oggettiva, perché non esiste un metro valido per tutti per tutti. Quindi, è soggettiva. Ciò che per me è utile, per te può non esserlo affatto. - L'utilità è relativa
È relativa perché dipende dalla scarsità del bene, dal contesto e da quanto se ne è già consumato.Ad esempio, un ombrello è molto utile quando piove, ma perde ogni utilità in assenza di pioggia. Inoltre, anche in caso di pioggia, possederne un secondo non apporta alcun beneficio: un solo ombrello è sufficiente, mentre un secondo risulterebbe inutile, se non addirittura ingombrante.
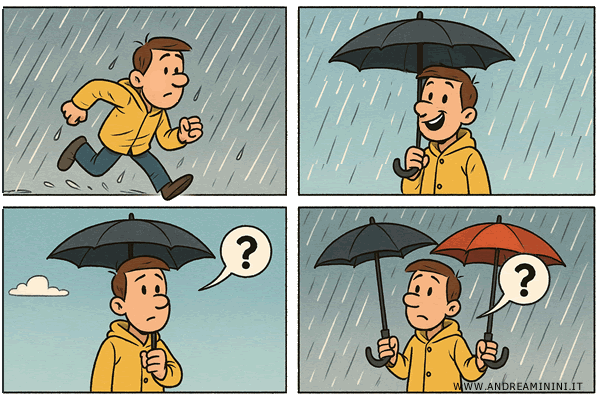
Un bene produce l'utilità d’uso quando soddisfa direttamente un bisogno individuale (es. un ombrello sotto la pioggia).
Tuttavia, perché un bene abbia anche utilità economica, non basta che sia utile, ci deve essere anche la scarsità.
In altre parole, non basta che qualcosa mi piaccia e sia utile, deve anche essere disponibile in quantità limitata.
Pertanto, non tutti i beni utili hanno anche un'utilità economica.
Ad esempio, l’aria è utile, ma non ha utilità economica perché è normalmente abbondante sulla Terra. L’acqua minerale, invece, lo è, perché viene prodotta, imbottigliata e venduta. Per questa ragione l'acqua minerale ha un prezzo. Salvo per i pochi fortunati che abitano vicino a una sorgente d'acqua minerale e che ne beneficiano gratuitamente.
A scanso di equivoci, da adesso in poi quando parlo di utilità, intendo l'utilità economica.
La legge dell’utilità marginale decrescente
Per comprendere bene come funziona, bisogna distinguere tre tipi di utilità:
- L'utilità iniziale è quella della prima unità consumata di bene. E' quella che soddisfa il bisogno in modo più forte.
- L'utilità marginale è l’aumento di utilità derivante dal consumo di una singola unità in più. Ad esempio, la seconda unità consumata, la terza, ecc.
- L'utilità totale è la somma delle utilità di tutte le unità consumate. Quindi, è la somma dell'utilità dalla prima unità consumata fino all'ultima.
Secondo questa legge, l’utilità marginale diminuisce con ogni nuova unità consumata.
In altre parole, la soddisfazione si assottiglia progressivamente, fino a diventare nulla o persino negativa (disutilità).
Ad esempio, quando mangio una pizza la prima fetta è deliziosa. La seconda ancora piacevole. Alla quarta o quinta, inizio a avvertire disagio perché comincio a essere sazio. La settima non la mangio se ho la sensazione che potrebbe causarmi mal di pancia.
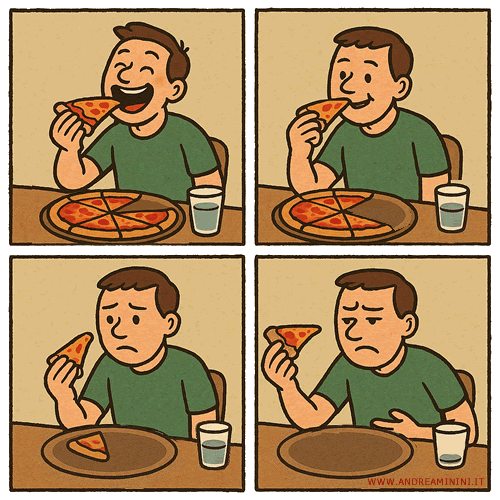
Come si misura l’utilità?
Oggi prevale l’approccio ordinale: si ordinano i beni in base alla preferenza, senza attribuire numeri.
In passato si utilizzava anche l’approccio cardinale, che tentava di assegnare un valore numerico all’utilità, è stato però in gran parte abbandonato perché troppo astratto e poco realistico.
Ad esempio, un consumatore può preferire una mela a una pera, e la pera a un pompelmo. Con l’approccio ordinale, è possibile ordinare le sue preferenze e rappresentarle come: mela > pera > pompelmo. Tuttavia, non è possibile stabilire quanto il consumatore preferisca una mela rispetto a una pera; sappiamo soltanto che, tra le tre, sceglierà prima la mela. Nell’approccio cardinale, invece, gli economisti tentarono di attribuire un valore numerico all’utilità: ad esempio, il consumo di una mela fornirebbe 10 unità di utilità, quello di una pera 5 e quello di un pompelmo soltanto 2. Questo metodo, però, presentava evidenti difficoltà, poiché non esiste un’unità di misura oggettiva dell’utilità.
E così via.
